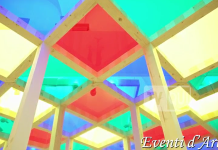Guercino è uno degli autori più indagati nella storia dellarte e la sua opera è dettagliatamente documentata dal Libro dei conti della sua bottega: quali sono quindi i nuovi documenti avanzati dai curatori della mostra e del catalogo a supporto di questa recente attribuzione? Anzitutto, il primo documento a contare nellattribuzione di un dipinto è il dipinto stesso. Ciò vuol dire che, solo dopo aver appurato che le sue caratteristiche tecnico-stilistiche si confanno al modus operandi di un determinato autore, si procede alla disamina delle fonti, le quali, a loro volta, contribuiscono a una maggiore comprensione dellopera stessa, permettendone linserimento, e in un contesto culturale specifico, e in un dato periodo del curricolo dellartista. Nondimeno, nel nostro caso, la prima traccia è indubbiamente offerta dal registro di bottega del Guercino, dal quale, in una nota del 25 agosto del 1631, si ricavano con chiarezza elementi utili allindividuazione dellopera, ovvero il soggetto («Giuseppe, et la moglie di Putifarro»), la tipologia compositiva («due mezze figure»), il pagamento («Schudi 130»), nonché la committenza del «Ser.mo Sig. Duca di Modena». Altre fonti, già note ma mai analizzate in funzione di questo dipinto, sono state invece le Vite de pittori e scultori ferraresi di Girolamo Baruffaldi del 1704 1707, ma edite postume nel 1841, e la biografia del Guercino di Gaetano Atti del 1861. Questultimo, in particolare, riferisce di un dipinto a mezze figure del Casto Giuseppe che era appartenuto agli Este e poi disperso, senza tuttavia specificare altro. Un ulteriore controllo dei documenti riguardanti le alienazioni estensi, fra cui la cosiddetta vendita di Dresda del 1746, nonché lInventario dei beni del 1692 1694, allorché alcuni quadri furono trasferiti dal Palazzo Ducale di Modena alla residenza estiva di Sassuolo, ha consentito di ricostruire lintera vicenda, per cui è probabile che il quadro dato anche il riferimento, per traslato, alle virtù vittoriose della castità e della fedeltà sia stato donato dal duca Francesco I alla nuora, Laura Martinozzi, in occasione delle nozze con il figlio Alfonso IV nel 1655. Al proposito, torna utile ricordare la citazione di un dipinto del Casto Giuseppe fra le «cose trovate, o restate nel monastero della Visitazione» e appartenute alla Serenissima Laura Martinozzi, la quale, esautorata dal figlio Francesco II dal governo di Modena, morirà a Roma nel 1687, dopo un tour fra le maggiori corti europee. Che importanza ha ai fini di questa attribuzione il disegno a penna di Guercino oggi conservato allAcademy of Art di Honolulu e considerato uno studio per il dipinto di proprietà della Zanasi Foundation? Solo oggi i disegni sono unanimemente considerati dalla critica come opere darte a sé stanti. Allepoca, al contrario, soprattutto per un accanito disegnatore come Guercino, i disegni costituivano un indispensabile strumento di lavoro. In particolare, Guercino era solito riutilizzare un espediente compositivo, o solo una figura di maggiore allure in dipinti di diverso soggetto e anche distanti nel tempo fra loro e ciò gli era consentito proprio dai disegni che, perciò, rappresentavano una sorta di promemoria o, meglio, una fonte inesauribile di modelli e idee compositive. Quanto al disegno di Honolulu, la sua importanza si deve anzitutto al fatto che è il solo disegno autografo pervenutoci di questa composizione (gli altri, infatti, si conoscono attraverso un calco della Royal Library e due copie conservate, luna, a Firenze e, laltra, ad Ascoli Piceno), a cui si aggiunge poi un valore documentale poiché è attraverso di esso che il Guercino ci informa dei suoi primi pensieri, vale a dire, della prima idea compositiva, permettendoci di seguirlo nelle diverse fasi del processo creativo: dalla prima inventio del disegno di Honolulu alla versione definitiva dipinta. Quali carte darchivio provano, o lasciano almeno ipotizzare, che il dipinto sia stato realizzato per il duca Francesco I dEste come si afferma nel titolo della mostra e del catalogo? La committenza è per lappunto specificata nel Libro dei conti del pittore, ma altre informazioni circa la presenza del dipinto nella Galleria Estense ci giungono dal biografo Carlo Cesare Malvasia e dalla Descrizione manoscritta del 1722 di Niccolò Panelli, mai data alle stampe e ciononostante citata da Luigi Salerno (1988) e da David Stone (1991) a proposito della confusione ingenerata nel tempo dalle fonti sui due dipinti estensi, entrambi di soggetto erotico, del Casto Giuseppe e di Amnon e Tamar.