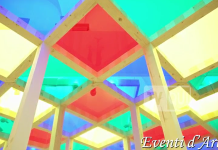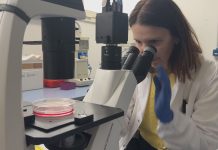La straordinaria collezione di capolavori dellarchitetto della lingua italiana è esposta fino al 19 maggio
Rimarrà aperta fino al 19 maggio prossimo e dal 2 febbraio scorso offre lopportunità di calarsi dentro a una delle più belle stagioni della nostra storia patria, quando lItalia politicamente e militarmente divisa in signorie era però unita dallarte, dallarchitettura, dalla musica, dalla lingua della cultura, dagli uomini di scienza, di gusto e dintelletto. Si tratta della mostra Pietro Bembo e linvenzione del Rinascimento. Capolavori da Bellini a Tiziano, da Mantegna a Raffaello allestita a Padova nelle sale del Palazzo del Monte di Pietà in piazza Duomo, non una semplice esposizione di capolavori, ma la filologica ricostruzione di un mondo privato e ideale, il paradiso degli occhi e dello spirito, un microcosmo esclusivo e trascelto: il Musaeum di messer Pietro Bembo (1470-1547), lelegante erudito veneziano che molti ricordano soltanto come il cardinale che amò Lucrezia Borgia e che invece è stato innanzitutto, e per tutti noi, il grande architetto della lingua italiana, colui che lavorando presso la stamperia di Aldo Manuzio seppe andare oltre Dante Alighieri per attingere alla perfezione di Francesco Petrarca e di Giovanni Boccaccio. Promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo insieme al Centro Internazionale Andrea Palladio e con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, questa iniziativa ha permesso «a quattrocento anni dalla sua dispersione di ricostruire concretamente la famosa collezione darte che il più grande letterato del Cinquecento aveva raccolto nella sua casa padovana di via Altinate» in un ventennio scarso di vita compreso tra lincarico di segretario di papa Leone X Medici e il cardinalato concessogli da papa Paolo III Farnese. In breve, tra la Roma aurea e medicea di fine Rinascimento e la Roma farnesiana e manierista. Le capillari e meticolose ricerche archivistiche condotte a tal fine dai curatori Guido Beltramini, Davide Gasparotto e Adolfo Tura, hanno consentito di conoscere esaustivamente e quindi riunire scientificamente una raccolta prestigiosa di cui non si conoscevano ancora i dettagli più raffinati, e principalmente di collocarla nel cuore della Padova rinascimentale come una creazione fondamentale per lepoca, il luogo delle Muse, il Musaeum appunto, «una nuova tipologia di raccogliere e presentare non solo larte, ma la conoscenza stessa» che da lì in poi diventerà universale. In tal modo messer Bembo impresse un deciso salto di qualità allo studiolo umanistico dei principi del Quattrocento e di pari passo con la marchesa di Mantova Isabella dEste Gonzaga donna che ne sapeva una più del diavolo in materia darte e di artisti diede impulso alle moderne gallerie di capolavori, quelli che lei teneva nella splendida e invidiatissima Grotta di Cortevecchia e che lui riunì nella casa patavina vicina alla chiesa degli Eremitani, dove lartista per eccellenza dei Gonzaga, Andrea Mantegna, aveva affrescato la Cappella Ovetari tra il 1448 e il 1457. Non a caso Pietro e Isabella si conoscevano molto bene e si scrivevano con affettuosa assiduità. Non a caso il più puro e originale Rinascimento dellItalia del nord si formò proprio tra la Mantova mantegnesca e la Padova di Donatello, passando per Ferrara estense. Nessuno stupore, dunque, nel ritrovarsi alla mostra di Padova davanti al dittico su tavola di Hans Memling già appartenuto al padre di messer Pietro, Bernardo, e oggi smembrato tra Washington e Monaco di Baviera; al San Sebastiano di Mantegna conservato in laguna; al Doppio ritratto di Andrea Navagero e Agostino Beazzano di Raffaello Sanzio, con cui Bembo strinse unamicizia profonda a differenza dei rapporti di ammirata ma fredda stima che allacciò con laltro genio del tempo, Michelangelo; ai due ritratti del gentiluomo veneziano eseguiti da Tiziano Vecellio, uno certo, laltro attribuitogli con buona plausibilità; a sculture romane, a teste in marmo e in bronzo, a gemme intagliate, a medaglie, vasi, fogli manoscritti, volumi miniati, lastre istoriate, Cupidi dormienti (proprio di quelli in candido marmo che facevano parimenti intenerire e impazzire la signora di Mantova!), a tutta quella magnifica e preziosa paccottiglia di affreschi in frammenti, di grottesche impolverate, di alabastri scheggiati e di monete imperiali che il Rinascimento aveva ereditato dal sofisticato tardogotico pisanelliano e che ancora andava cercando sotto il suolo di Roma, nella sepolta Domus Aurea neroniana, tuttintorno al Laocoonte ritrovato. E facendone le straordinarie collezioni di un nuovo Museo. La raccolta di Pietro Bembo venne dispersa a partire dagli anni Sessanta del Cinquecento a opera del figlio Torquato che, dopo aver ripetutamente deluso il padre in vita, ne disattese pure le chiare volontà testamentarie redatte nemmeno un ventennio prima e diede inizio a una serie di vendite rovinose per quella mandorla privata di bellezze e rarità. Tra gli acquirenti che si precipitarono a comprare figurano i Gonzaga, i Medici, i Farnese e i Wittelsbach, a riprova che casa Bembo era davvero ornata di tesori. Ma i fitti carteggi dellepoca hanno consentito agli studiosi di ricostruire i percorsi talora tortuosi seguiti dalle opere verso i nuovi proprietari e dunque di riconoscerle, recuperarle, riunirle. Più rispettosa verso le memorie e i desiderata paterni fu invece Elena Bembo, laltra figlia di messer Pietro, che si tenne i dipinti ereditati, tra cui il San Sebastiano di Mantegna, portandoli orgogliosamente in dote nella famiglia veneziana dei Gradenigo, di cui lei aveva sposato il nobile Pietro. Lì essi rimasero fino allinvasione napoleonica del 1796 e alla caduta della Serenissima, prendendo poi, e inevitabilmente, la via del mercato antiquario. In ragione di ciò oggi proponiamo ai nostri lettori questo viaggio fuori porta, perché è loccasione irripetibile di salire sulla macchina del tempo e tornare ad ammirare un luogo unico e perduto, ma finalmente ricostruito.