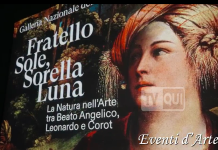A differenza del santuario di Fiorano, la chiesa di San Francesco in Rocca attigua al Palazzo Ducale di Sassuolo, piccola ma preziosissima cappella palatina che serviva alla famiglia per prendervi la messa quotidiana senza spostarsi dalla dimora di villeggiatura, è perfettamente conservata e integra in tutte le sue manifatture seicentesche e testimonia la medesima sontuosità barocca della reggia tanto da essere lideale e spirituale completamento del percorso iconografico del palazzo, quello che gli storici dellarte chiamano la decorazione architettonica di Sassuolo. Qui infatti finiva litinerario degli ospiti in visita, con il Te Deum di ringraziamento celebrato dentro la sacra navata intitolata al santo omonimo del duca. Qui chi vi giungeva poteva constatare che gli artisti e le maestranze arruolati per le pitture a fresco avevano compiuto un abbagliante capolavoro di coerenza stilistica e che lo straordinario risultato poteva dirsi il prodotto di una ben congegnata Officina sassolese. Peccato che oggi questo gioiello dellarte di casa nostra (unarte che proprio da qui dettò legge per tutta la prima metà del Seicento, e anche oltre) sia ancor meno visibile del palazzo che conclude e rifinisce, poiché compreso solo su richiesta nel percorso di visita e aperto solo in occasione di particolari ricorrenze religiose (in cima a tutte il Giovedì Santo). Costruita tra il 1650 e il 1653, cioè durante le fasi conclusive della residenza ducale, e costruita sul lato opposto della piazza rispetto a quello dellantica chiesa già presente e consacrata al medesimo santo per via del progetto della Peschiera ideata da Gaspare Vigarani, la chiesa vide allopera la consueta e premiata ditta franco-romana Avanzini & Boulanger, il primo, larchitetto Bartolomeo, impegnato a disegnarne strutture e linee, cappelle e cantorie, passaggi segreti per il palazzo e corridoi privati, il secondo, il pittore Jean, a decorarne soffitti e pareti, volte e pennacchi, finte colonne e arazzi prospettici con la medesima e strabiliante tecnica illusionistica già dispiegata nelle stanze della reggia. E senza mai dimenticare di esaltare insieme alle glorie celesti del santo di Assisi le glorie terrene del duca di Modena. A questo proposito, Vincenzo Vandelli ha individuato nella decorazione a fresco della chiesa, eseguita dal Boulanger coadiuvato dai suoi allievi e dai due esperti quadraturisti Baldassarre Bianchi e Gian Giacomo Monti, alcuni ovali e alcuni cartigli recanti figurazioni allegoriche delle virtù del principe e cifre intrecciate a scopi enigmistico-enigmatici che una volta sciolte formano il nome Francesco. Tali espedienti decorativi, che giunsero allepoca barocca direttamente da quella rinascimentale, e proprio da quel Rinascimento padano che nelle città di Ferrara e Mantova ebbe le capitali per eccellenza di questi cerebrali vezzi e di questi oscuri capricci, tali espedienti, appunto, confermano lessenza di vero estense di Francesco I, sovrano non solo capace di usare il passato dinastico come propaganda e ratifica del suo presente, ma perfettamente consapevole di riutilizzarlo con efficacia in queste sottili pieghe simboliche oltremodo raffinate ed esclusive. Testimoniando così di averlo conosciuto profondamente. E di averlo valutato più significativo e valido, a livello politico, del passato sabaudo, di cui pure lui era erede per parte di madre. Oltre a essere un sacello darte, la cappella palatina di Sassuolo custodisce la veneratissima reliquia del Sacro Tronco donata alla città nel XVI secolo dallallora signore Marco Pio, incastonata nellaltare di destra e ancora oggi portata in processione nei giorni che precedono la Pasqua. Di Michele Desubleo, altro francese allopera nei cantieri ducali modenesi ma al servizio degli eredi di Francesco I, è la pala daltare raffigurante San Francesco in estasi posta sullaltare maggiore.