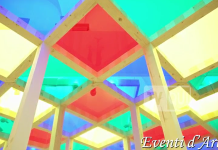Fino al 27 ottobre è visibile lo straordinario impiantito a commesso marmoreo del Duomo di Siena
Il nostro Speciale dedicato allarte ama andarsene in giro per lItalia a scoprire mostre e tesori. Questa settimana il suggerimento che indirizziamo ai lettori di Modena Qui riguarda un capolavoro di assoluta bellezza che per la gran parte dellanno rimane coperto per ragioni di salvaguardia e che solo sul finire dellestate viene temporaneamente mostrato al pubblico. Lanno scorso il successo è stato talmente grande, 350mila visitatori in poco più di due mesi, che per il 2013 i responsabili del patrimonio storico-artistico del Duomo di Siena hanno deciso di riproporre levento e scoprire quindi lo straordinario pavimento della cattedrale, realizzato tra il XIV e il XIX secolo con la tecnica del commesso marmoreo e con materiali di provenienza locale. Solitamente il prezioso impiantito è del tutto protetto dal passaggio e dal calpestio dei tantissimi fedeli che ogni giorno accedono a questo luogo di culto o, talora, solo parzialmente visibile, per cui loccasione di vederne per intero il tappeto di marmo disegnato a graffito è davvero unica e programmata fino al 27 ottobre prossimo. Giorgio Vasari, lartista e architetto aretino la cui fama è legata soprattutto al trattato Vite de più eccellenti pittori, scultori e architetti italiani, da Cimabue insino a tempi nostri, lo definì nella seconda metà del Cinquecento «il più bello, grande e magnifico pavimento che mai fusse stato fatto» e a tuttoggi tale primato si può dire ancora imbattuto e blindato, considerando anche che Vasari descriveva unopera non ultimata, una sorta di immenso retablo orizzontale che nei tre secoli successivi al suo avrebbe collezionato altri pregevolissimi apporti soprattutto in termini di esecuzione. I cartoni preparatori del complesso programma iconografico che ricopre il pavimento della cattedrale toscana sono firmati dai maggiori artisti dellarea senese rinascimentale, a partire da Stefano di Giovanni di Consolo, detto il Sassetta, per arrivare al manierista Domenico Beccafumi passando per Domenico di Bartolo, Matteo di Giovanni e la collaborazione del forestiero Bernardino di Betto, meglio noto come Pinturicchio, il valentissimo pennello umbro che aveva stregato i Borgia e dunque dipinto le loro fosche stanze romane incrostandole del baluginio di pietre preziose. A lui si deve, in particolare, il celebre riquadro con il Monte della Sapienza, «raffigurazione simbolica della via verso la Virtù come raggiungimento della serenità interiore», realizzato nel 1505. Il Beccafumi, invece, si distinse in questa fabbrica, e specificamente nelle Storie di Mosè sul Sinai, per aver portato a perfezione la tecnica del commesso marmoreo «con risultati di luci e ombre assimilabili al chiaroscuro del disegno». Il percorso di visita si snoda attraverso le tre navate seguendo i grandi simboli e i grandi personaggi dellantichità classica e pagana: la Lupa che allatta Romolo e Remo, legiziano Ermete Trismegisto, le dieci Sibille, i filosofi Socrate, Cratete, Aristotele e Seneca. Nel transetto e nel coro è invece illustrata la storia del popolo ebraico, a cui fa seguito la vicenda della salvezza compiuta da Cristo, che però non è mai «rappresentato nelle raffigurazioni del pavimento, ma solamente evocato, poiché presente sullaltare, luogo verso cui converge lintera rappresentazione artistica e religiosa». Nellesagono sotto la cupola, dove protagonista è la mano eccellentissima di Domenico Beccafumi, si incontrano poi le Storie di Elia e Acab, le Storie di Mosè e il Sacrificio di Isacco. Inutile dire che le bellezze del duomo di Siena non si esauriscono qui, per quanto la discoperta del pavimento e la sua apertura al pubblico siano di forte impatto e di conseguente richiamo. Nellabside, ad esempio, si trovano anche gli affreschi (purtroppo pesantemente ridipinti dopo un terremoto) e gli angeli in bronzo del Beccafumi, e le tarsie lignee di fra Giovanni da Verona. Queste ultime riproducono in un luogo sacro le immagini tipiche degli studioli rinascimentali, spazi di riflessione intellettuale e spirituale in cui il signore amava circondarsi di paesaggi, nature morte, vedute urbane, ripiani carichi di libri, di strumenti musicali e di poliedri sfaccettati insieme con teschi e clessidre quali simboli della vanità delle glorie terrene.