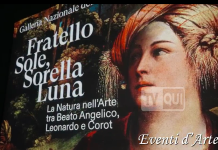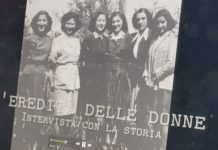Il fascino magnetico delle collezioni estensi Laccesissimo e mai dissimulato desiderio dei pontefici romani di riprendersi Ferrara togliendone la giurisdizione sovrana ai loro vicari di sangue estense (Giulio II della Rovere ci aveva già provato con guerresca determinazione prima che Clemente VIII Aldobrandini ci riuscisse sul finire del Cinquecento con genealogica astuzia) fu alimentato ancor prima che dalle prerogative territoriali millantate sulla scorta della (peraltro falsa) Donazione di Costantino, dallimmensità numerica e qualitativa del patrimonio darchitettura e darte che la città padana aveva accumulato dentro e fuori le sue mura proprio grazie allo splendido e assiduo mecenatismo degli Este. La rapace spoliazione messa in atto dagli inviati del cardinale Pietro Aldobrandini, nipote del papa, allinterno dei superbi camerini dalabastro del duca Alfonso I allindomani della Devoluzione del 1598 (ovvero il rientro ufficiale di Ferrara nei possedimenti della Santa Sede con conseguente fuga degli Este nei loro territori imperiali di Modena e Reggio) la dice lunga, del resto, sullansia di quellattesa: i dipinti di Giovanni Bellini, i quadri di Dosso Dossi, del Garofalo e di Girolamo da Carpi, il ciclo dei Baccanali di Tiziano vennero strappati dalle pareti dei magnifici ambienti ducali della via Coperta quasi fossero affreschi. A distanza di qualche anno, quando ancora gli Este già regnanti a Modena non erano ancora riusciti a recuperare interamente i loro beni personali, ci pensò un cardinale della famiglia Borghese a finire lopera del collega Aldobrandini portandosi via a piene mani una serie di gioielli dal valore inestimabile. E pensare che proprio in quel periodo, approfittando della sensibile debolezza della casata atestina che ci impiegherà decenni a superare il trauma ferrarese (e che forse non lo superò mai), i Borghese lavoravano furbescamente alla messa a punto di un altro tremendo furto ai danni degli Este, la sottrazione a loro tramite una cerebrale ipotesi di acquisizione per prolungata usucapione del casino da diporto del cardinale Ippolito I collocato sulla sommità di Monte Cavallo, quel delizioso e ornatissimo villino di delizie con vigna tuttattorno che a forza di ampliamenti sarebbe diventato nei secoli successivi il Palazzo del Quirinale, dimora di papi, di principi e di re. Oggi, mestamente, di presidenti… Daltra parte, lansia estense di portar via da Ferrara alla volta di Modena tutto ciò che era privato e dunque possibile sottrasse molti capolavori, manufatti, ricchezze, memorie e testimonianze alle avide grinfie papali. Il colossale trasloco di beni mobili che cominciò sotto il duca Cesare, e che sarebbe continuato ancora durante il ducato di suo nipote Francesco I con ripetute incursioni di emissari estensi dentro il Palazzo dei Diamanti ferrarese per trasferire nella nuova capitale quanto ancora non era stato legittimamente restituito alla famiglia, consentì di salvare la gran parte del patrimonio dinastico accumulato tra Medioevo, Tardogotico e Rinascimento e di dare quindi il primo, magnifico impulso alla galleria modenese e seicentesca, poi celebre e celebrata presso tutte le corti dEuropa, con pezzi che andavano (e tuttora, per nostra fortuna, vanno) dagli ovali di Annibale e Agostino Carracci ai rombi di Dosso Dossi a due raffinate fiasche di manifattura veneziana della seconda metà del XV secolo probabilmente presenti sullelegante tavola ducale di Ercole I e di Eleonora dAragona. Breve storia della nostra pinacoteca Il nucleo delle opere darte e dei preziosi manufatti provenienti da Ferrara, e da Ferrara via via recuperati, costituì quindi la primissima collezione e loriginaria galleria di capolavori degli Este di Modena, fin da subito affastellate dal duca Cesare nelle sale di rappresentanza del fortilizio estense costruito da Obizzo II nel 1289, il castello dalla scomoda architettura marziale che accolse e ospitò lintera famiglia spatriata in mancanza di una dimora più confortevole e signorile, e in attesa che qualcuno (Francesco I) lo trasformasse in un sontuoso palazzo dal disegno barocco, sul modello delle residenze pontificie e prelatizie. La raffinata raccolta darte del cardinale Alessandro, fratello del duca, entrata in castello alla morte di lui nel 1624 rappresentò il primo significativo accrescimento delleredità ferrarese, a cui fece seguito la committenza allartista di corte Sante Peranda di una serie di ritratti dei membri di casa DEste per la costituzione (irrinunciabile per lepoca) di una galleria dinastica di nomi e di volti da aggiungere a quella degli antenati illustri. Stando allinventario ordinato dal duca Alfonso III nel 1629 prima di abdicare in favore del primogenito Francesco, i dipinti della primitiva collezione erano sparsi in varie camere, già ornate alle pareti da damaschi, velluti, cuoi e arazzi, e i più prestigiosi riuniti nei tre camerini dorati dellinquieto sovrano, votatosi nello stesso anno alla vita religiosa. Lavvento di Francesco I dEste sul trono modenese significò laffermazione di Modena Capitale e quindi il consapevole, volontario e voluto allestimento di una galleria darte che, secondo i più autorevoli ed efficaci costumi degli avi ferraresi, affermasse e legittimasse ancor più i sovrani estensi alla guida del loro dominio, ridotto, sì, e depauperato dal papa, ma pur sempre protetto dallimperatore. Il giovane e intelligente signore mise immediatamente in atto il meccanismo che aveva funzionato per secoli a Ferrara, la ratifica del diritto dinastico e politico di un principe a regnare tramite la promozione e il mecenatismo artistico. Ne vennero quattro meravigliose camere di parata en enfilade nelle quali «il solo criterio di esposizione delle opere doveva essere, appunto, la meraviglia, quattro ambienti per il trionfo dello stupore e dellincanto, preceduti da tre stanze danticamera a loro volta affrescate e ornate di dipinti per fare da adeguato preludio allo spettacolo mozzafiato che seguiva. Nel soffitto a cassettoni della prima camera vennero inseriti i rombi a firma di Dosso Dossi provenienti dal Castello Estense di Ferrara. Nel soffitto della seconda furono posizionati gli ottagoni di Tintoretto con le Metamorfosi di Ovidio acquistati dagli agenti del duca sul mercato veneziano. Il soffitto della terza fu decorato con gli splendidi ovali carracceschi staccati dallappartamento di Virginia de Medici, moglie del duca Cesare, in Palazzo dei Diamanti. I vani nel soffitto dorato della quarta furono riempiti con una serie di ritratti di antenati estensi, la galleria dei visi di famiglia che non poteva mancare in una casa di nobili regnanti. Ovunque, lungo le pareti tappezzate di rosso cardinalizio e incorniciate di stucchi aurei cerano quadri, sculture, sedie debano, tavolini davorio, suppellettili di marmo e cascami di velluto operato». Per dirla con Jadranka Bentini, che ha acutamente sintetizzato gli effetti di questa disposizione, «i dipinti appartenenti in antico a sfondati erano collocati a soffitto, giustapposti per grandezze diverse ma in armonia dimensionale in relazione alle pareti, alle finestre e alle porte, e sempre con presenze chiave intorno alle quali ruotavano opere capaci di esaltare quella centrale». In breve, una grandiosa invenzione estetica e scenografica, figlia non per caso del grande sovrano che fu per Modena, per Sassuolo e per gli Este tutti Francesco I. Limpronta di lui sulla galleria era stata, del resto, talmente incisiva, volitiva e particolare che da un inventario redatto tra la fine del Seicento e linizio del Settecento si deducono ancora chiaramente la sua personalissima azione e la sua precisa intenzione nel promuovere «una raccolta pianificata e sistematica che sarebbe durata poi quasi senza alterazione per quasi un secolo». Un secolo, in verità, è dir tanto perché malgrado lerede diretto di Francesco I, Alfonso IV, non abbia dato sostanziali contributi a causa di una morte assai prematura (1662) e la nuora, Laura Martinozzi, reggente del ducato per dodici anni (1662-74), non abbia acquistato e incrementato più di tanto talora per mancanza di denari, talora per scelte differenti, limitandosi per la galleria ducale a commissionare un inventario (1663) ancor oggi utilissimo agli studiosi del collezionismo estense, già durante il ducato del nipote Francesco II (1674-1694) cominciò una fase di cospicue dispersioni e alienazioni. Linfingardo sovrano, infatti, concesse largamente ai cugini da lui molto amati, e favoriti anche al potere, Cesare Ignazio, Luigi e Foresto dEste, di attingere alle preziose raccolte di famiglia per avere quadri e suppellettili con cui ornare le rispettive dimore di città e di campagna. Cesare Ignazio, il prediletto, ne portò via dal Palazzo Ducale, e senza nemmeno doverli trafugare, tantomeno pagare, ben quattrocento. Unica attenuante per Francesco II, melomane di estrema qualità, fu di avere almeno in parte colmato i vuoti pittorici causati dalle sue irresponsabili distrazioni con capolavori assoluti della liuteria dellepoca, con quegli strumenti musicali lignei e marmorei che suonava di persona o attorno ai quali patrocinava concerti di straordinario successo, di immediata risonanza. Lo zio che gli successe, Rinaldo I, essendo morto Francesco II senza eredi, cercò senza indugi di rimediare a tanta perdita, allontanando da Modena i cugini arraffoni e adoperandosi attivamente per far rientrare in palazzo le opere ancora individuabili, riconoscibili e rimaste entro i confini estensi. Ma la calata in Italia degli eserciti francesi e un suo necessario esilio tra Bologna e Roma lo costrinsero a nascondere anche quello che gli era rimasto in casa e a sperare che ciò che non si trovava lì fosse, tutto sommato, più al sicuro. Fu tuttavia in un anno del suo regno, precisamente il 1712, che si verificò il prodromo della tragedia: Augusto III di Polonia in visita ufficiale alla corte degli Este si innamorò allora e a tal punto della loro galleria di capolavori da non riuscire a dimenticarla più. Peggio: da volerla a tutti i costi e da far di tutto per averla. Unossessione che lo perseguiterà per gli anni a venire e che stando alle parole di Charles de Brosse vergate nel 1740 in occasione di un viaggio a Modena avevano il loro bel fondamento: la collezione darte degli Estensi era a quel tempo «un trionfo del gusto, la meglio tenuta, la meglio ordinata e ornata dItalia», mille volte più bella delle caotiche raccolte romane, distribuita con intelligenza e misura, curata, custodita, ben esposta e con un apice assolutamente vertiginoso, la correggesca Notte, davanti alla quale tutti i visitatori trasecolavano. Proprio lincurabile infatuazione di Augusto III segnò il destino del nuovo ordinamento della galleria voluto dallerede di Rinaldo I, suo figlio Francesco III, che seguendo i consigli del pittore di corte e soprintendente ai dipinti Antonio Consetti fece esporre la collezione secondo i dettami delle più prestigiose raccolte principesche dEuropa, ovvero sistemandola nelle sei sale affacciate sullattuale piazza Roma e affiancando ai cimeli della pittura e della scultura il medagliere, la biblioteca di famiglia e larmeria. Purtroppo lelegante allestimento inteso a mostrare e dimostrare la grandezza della dinastia tramite lesposizione dei tesori accumulati nei secoli durò pochissimo, nemmeno un decennio, giacché nel 1746, sotto lurto della guerra di successione austriaca nella quale Francesco III dEste si era mosso da gran pasticcione procurando a Modena antipatie e nemici su tutti i fronti, lassillo di Augusto di Polonia ebbe fine e il sovrano nordico poté portarsi a casa cento capolavori (cento!) della quadreria estense in cambio della sostanziosa cifra (100.000 zecchini) che consentì al duca di rifiatare, garantirsi un temporaneo esilio al sicuro e comprarsi qualche opportuna alleanza. Francesco III si dispiacque sempre poco di questa sciagurata alienazione passata poi alla storia come vendita di Dresda. Sua moglie, la duchessa doltralpe Carlotta Aglae dOrléans, spregiudicata e squattrinata come nessunaltra mai nella storia di Ferrara e di Modena, non se ne dispiacque affatto. Peccato, però, che con i dipinti di Correggio (ben quattro, tra cui la luminosissima Notte), di Tiziano, di Veronese, dei Carracci, di Dosso, di Guercino, di Guido Reni, di Caravaggio, di Rubens, di Parmigianino, di Garofalo, e di svariati altri artisti tra maggiori e minori, partiti alla volta della capitale della Sassonia si aprisse nella collezione atestina uno squarcio mai visto prima, e al quale non poterono certo porre rimedio le pur numerose copie ordinate, e affidate a maestri di nome e di qualità, o le ruberie di opere da chiese e castelli secondo la consuetudine autoritaria che era già stata di Francesco I. Gli affreschi di Nicolò dellAbate staccati dal Camerino dellEneide di Giulio Boiardo allinterno della Rocca di Scandiano giunsero in questo modo a Modena, e a Modena sono tuttora conservati. Verso i nostri giorni Le aggressive spoliazioni napoleoniche durante loccupazione che andò dal 1796 al 1814, le imperiali malversazioni di Giuseppina Beauharnais, moglie di Napoleone, che portò via dal Palazzo Ducale duecento cammei di immenso valore per la residenza neoclassica della Malmaison, i vergognosi furti del dittatore Luigi Carlo Farini con consorte al seguito (la signora tolse dal guardaroba della dimora ducale tutti gli abiti lasciati dallultima duchessa, Adelgonda di Baviera) si abbatterono su ciò che rimaneva della grandiosa raccolta darte degli Este, nel 1854 rinominata da Francesco V Reale Galleria Estense, causandone ulteriori depauperazioni. Ma il colpo di grazia le venne inferto con il trasferimento del 1880 nel sottotetto dellAlbergo delle Arti, lattuale Palazzo dei Musei, dove la pur sempre ingente collezione venne sistemata quando il Palazzo Ducale divenne la sede dellAccademia Militare. Il luogo, inizialmente indicato come provvisorio poiché limitato, divenne poi definitivo, tantè che molte opere, per problemi di spazio, sono state depositate presso il palazzo Coccapani di corso Vittorio Emanuele II. Riaperta al pubblico nel 1894 grazie allimpegno devoto di Adolfo Venturi, la pinacoteca statale modenese, rimpinguata negli anni da nuovi acquisti e acquisizioni (valga per tutti lo splendido SantAntonio da Padova del ferrarese Cosmè Tura giunto nel 1906) porta oggi il nome completo di Galleria Museo e Medagliere Estense avendo acquisito anche il Museo delle Medaglie e delle Antichità istituito nella prima metà del XIX secolo da Francesco IV e in un primo tempo annesso alla Biblioteca Estense. Oggi il suo pezzo più simbolico e rappresentativo è il Busto di Francesco I dEste scolpito nel marmo da Gian Lorenzo Bernini (1650-51), unopera che toglie il fiato per maestosità e bellezza. Unopera dellassolutismo sovrano che incute una commossa soggezione. E che infatti nessuno ha mai portato via…